- Homepage
- «Imprese poco dinamiche: per…
News
«Imprese poco dinamiche: per uscire dalla crisi scommettiamo sulle filiere integrate»
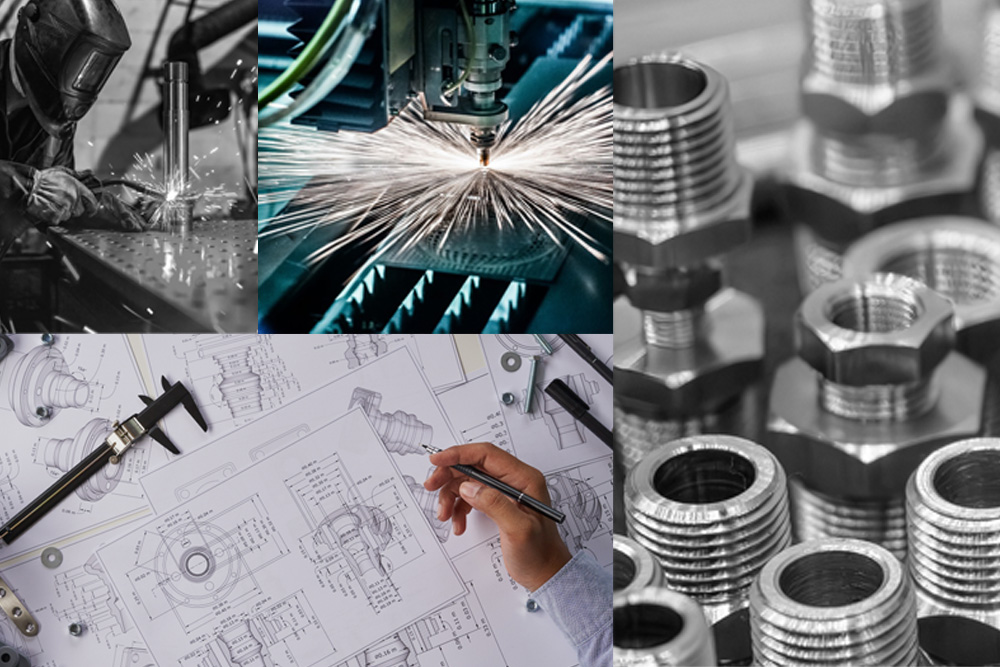
Terza e ultima puntata dell’inchiesta di Confartigianato Imprese Varese sulla crisi del manifatturiero. Dopo Marco Fortis (che spezza una lancia a favore del settore, ancora capace di trainare l'economia mondiale) e Mauro Gallegati (che non nasconde le preoccupazioni per un’Italia che ha dimenticato il valore del “fare”), ora è la volta di Alessandro Arrighetti, già professore in Economia Industriale all’Università di Parma. Che dice: «Il nostro Paese ha dimenticato il modello produttivo, originale, delle piccole e medie imprese. Che non sono mai state considerate una vera leva di sviluppo. Invece, quelle realtà che si dimostrano particolarmente dinamiche sono altamente competitive perché flessibili e capaci di offrire prodotti innovativi, tecnologici ed eterogenei».
Cosa fare per uscire dalla “trappola della staticità”? «Bisogna scommettere sulle filiere integrate e, soprattutto, sostenere le piccole imprese con incentivi mirati e scelte di politica industriale selettiva».
Professore, la manifattura italiana sta vivendo un lento declino, oppure no?

Bisogna partire dal fatto che si deve parlare di eterogeneità, e non di omogeneità, del settore manifatturiero. Negli anni si è registrata una polarizzazione dei comportamenti delle imprese: se alcune hanno avuto una dinamica modesta, recessiva, di contenimento o addirittura difensiva, altre si sono dimostrate dinamiche e hanno ottenuto risultati apprezzabili nella loro crescita. Quando si parla di declino, quindi, bisogna considerare che alcune imprese salgono, altre scendono. Ma il declino – stagnazione degli investimenti e modesta crescita della produzione - riguarda gran parte dell’Europa e delle economie occidentali. Poi, c’è una contrazione, se non un ripiegamento, della domanda perché le nostre imprese manifatturiere esportano solo il 30% della produzione, mentre la maggior parte va al mercato interno. Infine, negli anni Novanta è subentrata la ristrutturazione delle grandi imprese e la privatizzazione di quelle statali: questo è un peso che si avverte ancora oggi perché l’adattamento delle grosse realtà di quegli anni, e la loro mancata ristrutturazione, ha portato alla loro debolezza e, di conseguenza, ha indebolito il manifatturiero.
E per quanto riguarda le piccole e medie imprese?
Il valore del loro modello produttivo, altamente originale, è stato dimenticato. Nelle Pmi, e non solo nei distretti, contano le economie di specializzazione e non di scala. Di riflesso, queste aziende sono diventate la causa presunta di una insufficiente crescita della produttività. Le piccole imprese non sono mai state considerate come una vera leva di sviluppo.
In cosa sbaglia la narrazione economica mainstream?
Si affida a indicatori sbagliati: quando si parla di produttività non si deve fare riferimento ai prezzi costanti, ma ai prezzi correnti. Negli ultimi venticinque anni, l’Italia ha dimostrato una capacità straordinaria nel trasformare prodotti con un forte incremento dei prezzi anche sui mercati internazionali. In pratica, le imprese hanno aumentato i prezzi più di quanto hanno fatto i loro concorrenti, eppure le vendite non sono mancate. In questo sta la loro, grande, competitività. Il punto è che ci si muove su strategie di prezzo non legate al contenimento dei costi, ma ad una differenziazione – anche all’interno dello stesso settore – trainata dall’ampliamento della gamma dei prodotti, dalla loro innovazione, dalle tecnologie utilizzate, dalla customizzazione e dalla flessibilità delle imprese. E’ questo il cuore pulsante del nostro manifatturiero, e i clienti sono disposti a pagare un prezzo più alto perché riconoscono l’elevato valore aggiunto garantito dalle aziende italiane.
La globalizzazione ha inciso sulle difficoltà del manifatturiero? Se sì, le filiere corte potrebbero essere un valido aiuto per riprendere la giusta spinta?
Per l’Italia, la globalizzazione è stata una grande opportunità e ha permesso alle nostre aziende di essere presenti sui mercati più diversi. Diciamo che è un ingrediente centrale per lo sviluppo della manifattura italiana. Certo, ha portato con sé il rischio della fragilità perché la distanza complica i tempi di consegna e il controllo della qualità. Affidarsi a fornitori più vicini è generalmente positivo, però penso si avverta la necessità di creare contesti produttivi locali che possano operare all’interno di un territorio integrato, sia per quanto riguarda i semilavorati che per tutti quei beni che sono considerati immateriali (consulenze, digitalizzazione, formazione dei collaboratori). Fare a meno della globalizzazione non è possibile, però sarebbe opportuno rafforzare le filiere corte in modo selettivo per raggiungere un livello di competitività soddisfacente.
Sulla produttività della manifattura italiana pesa la presenza di un “eccesso” di imprese molto piccole?
Il problema della piccola impresa è legato alla produttività, ma questo non vuol dire che le Pmi siano un peso: anche se hanno livelli di produttività inferiori a quelli delle grosse imprese, sono ugualmente necessarie. Il punto sul quale concentrarsi è la capacità di ogni singola impresa a valorizzare nel tempo le risorse che possiede. Le imprese che cambiano e innovano meno sono nel segmento delle imprese piccole, ma anche tra queste si trovano numerose realtà dinamiche. Piuttosto, dovremmo parlare delle aziende “attardate”, lontane dal livello di frontiera della produttività efficiente. Il vero problema, quindi, è che tra le piccole realtà ci siano imprese ritardatarie.
Quali sono i punti deboli della manifattura italiana sui quali si deve intervenire?
La capacità, o meno, dell’impresa di saper valorizzare le proprie risorse: è questo che si deve fare. Mantenere una quota di imprese molto statiche, non sempre piccole, che operano su mercati locali ristretti, costituisce un grave limite per il sistema produttivo italiano. Se un’impresa continua a ripetere ciò che faceva dieci anni fa, il sistema si blocca. Quella parte di manifatturiero che si attarda sullo sviluppo dei propri modelli di gestione, e internazionalizzazione, è ormai inappropriato per il mondo di oggi. E allora insisto: il cambiamento, a livello territoriale e locale, deve essere sostenuto con incentivi, e con scelte di politica industriale selettiva, diretti alle imprese meno dinamiche per sostenerle nel loro percorso di innalzamento qualitativo dei prodotti, delle tecnologie utilizzate e dei modelli organizzativi. Sia chiaro che qui non si sta parlando di cambiare le dimensioni di impresa, ma di definire una strategia e inserirsi in un percorso che aiuta gli imprenditori ad uscire dalla trappola della staticità.
Quali sono i punti di forza che non vengono valorizzati in pieno?
Un elemento di grande importanza, spesso trascurato, è rappresentato dalla ricchezza e completezza della gamma di prodotti offerti e dall’estensione delle tecnologie e dei saperi posseduti dalle imprese manifatturiere. Una varietà di competenze che molte ricerche hanno segnalato come unica per un Paese di medie dimensioni come il nostro. Questo dato rappresenta una straordinaria opportunità per sviluppare settori, e applicazioni nuove, guardando alla molteplicità di filiere che potrebbero nascere. Mi spiego: se parlo di economia della cura non penso solo agli ospedali, ma anche a tutto quel manifatturiero – spesso molto avanzato – che lavora nelle apparecchiature medicali, nella componentistica, nell’automazione. Frequentemente, il livello di coordinamento di filiera è limitato, e molte delle iniziative di valenza strategica che potrebbero sorgere non vengono colte e nemmeno immaginate. Esempi di nuove architetture di filiera (forse, nuovi settori) che integrino servizi e produzioni manifatturiere, e definiscano nuove opportunità di crescita e di specializzazione anche sui mercati internazionali, sono molto più diffusi di quanto si pensi. Bisognerebbe individuarle, e trasformarle, in progetti di politica industriale attiva e di aggregazione di imprese.
SCHEDA DI SINTESI: TRE VISIONI PER RILANCIARE IL MANIFATTURIERO ITALIANO
| TEMA | MARCO FORTIS | MAURO GALLEGATI | ALESSANDRO ARRIGHETTI |
| Diagnosi della crisi | Rifiuta il catastrofismo: il manifatturiero italiano è resiliente e competitivo | Crisi strutturale da 30 anni causata dalla globalizzazione e dalla finanza speculativa | Polarizzazione: imprese dinamiche vs. imprese statiche e ritardatarie |
| Ruolo delle Pmi | Fondamentali per la flessibilità delle filiere e la tenuta sociale | Sottocapitalizzate, ma creative e capaci di adattarsi | Modello originale dimenticato: vanno sostenute con politiche selettive |
| Produttività | Non è tutto: le imprese italiane preferiscono conservare competenze | Va legata alla qualità e alla customizzazione, non ai costi | Indicatori sbagliati: la competitività si misura anche sui prezzi correnti |
| Politica industriale | Serve un nuovo Piano simile a Industria 4.0 e meno burocrazia | Deve partire dall’alto, sostenere filiere e cultura industriale | Selettiva e mirata, per aiutare le imprese meno dinamiche a evolvere |
| Tecnologia e innovazione | Investire in digitale e IA per rafforzare le eccellenze | Strumento chiave per uscire dalla crisi e personalizzare i prodotti | Differenziazione e ampliamento della gamma sono leve di competitività |
| Filiere e territorio | Le filiere corte hanno aiutato durante le crisi | La desertificazione produttiva ha indebolito i territori | Rafforzare filiere corte e contesti produttivi locali integrati |
| Globalizzazione | Ha messo alla prova il sistema, ma l’Italia ha reagito bene | Ha creato disuguaglianze e precarietà | Opportunità da gestire con filiere corte e coordinamento locale |
| Visione strategica | Dare continuità alle eccellenze, anche senza eredi | Scommettere sul “fare” e sull’economia reale | Individuare nuove architetture di filiera e settori emergenti |
Davide Ielmini (Fine)

