Dove intervenire quando le crisi diventano sistema: liquidità e modelli di business
Il coordinatore del Centro Studi Imprese e Territorio Antonio Belloni analizza l'aumento dei fallimenti aziendali (+17,2% nel 2024) distinguendo tra choc esterni e fragilità strutturali. La ricetta: agire su finanza e marginalità

di Antonio Belloni *
Anche nel 2025, come dopo ogni evento stressante aumentano crisi aziendali, fallimenti e liquidazioni, occasionalmente accelerati da cali dei ricavi e incertezze sui mercati, ma sempre sostenuti da una gestione finanziaria al limite delle possibilità e da modelli di business che spesso non rendono.
È quindi giusto agire sulle cause improvvise, ma è colpevole non farlo su quelle durevoli.
CRISI ESTERNE
Il 1816 è stato un anno senza estate.
Un anno prima, il Monte Tambora in Indonesia ha eruttato così violentemente da fare 10.000 vittime subito e da farne circa 70.000 nei mesi successivi. Per intenderci: un’esplosione dieci volte più forte del Krakatoa del 1883.
Ma le conseguenze non furono solo locali.
È stata infatti un’attività geologica talmente estrema da sconvolgere un mondo non ancora globalizzato e connesso come quello di oggi, stravolgendone i sistemi meteorologici, scatenando malattie, destabilizzando regimi politici ed economie.
Nel mondo di oggi, di eventi stressanti come questo le imprese ne affrontano ormai uno ogni 5 o 6 anni. E ad ogni evento stressante lasciano sul campo morti e feriti. Nella meccanica e la moda, per esempio, dal 2021 al 2024 sono venute meno 19 imprese al giorno.
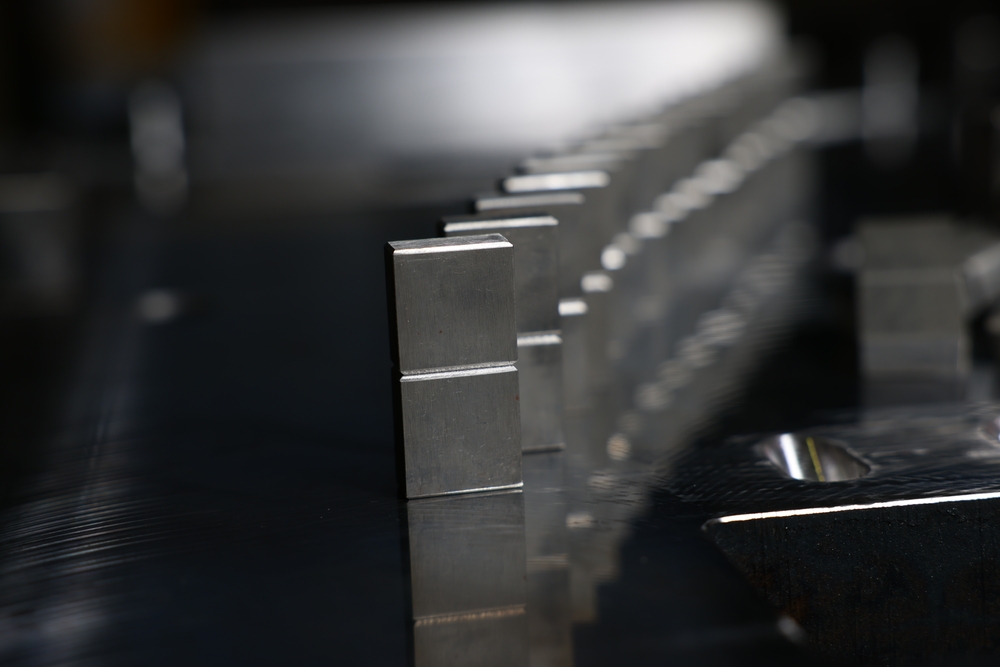
Se provassimo a mettere in fila le crisi recenti, verrebbe fuori un elenco simile a questo:
- crisi post-11 settembre (2001): ripercussioni a livello globale, incertezze economiche e destabilizzazione dei mercati;
- crisi finanziaria globale (2007-2008): dal crollo di Lehman Brothers l’impatto è diffuso e pesante e porta a recessioni in diversi paesi, compresa l'Italia;
- crisi del debito sovrano dell'Eurozona (2011): difficoltà economiche in Grecia e in altri paesi dell'Eurozona sollevano preoccupazioni sul debito pubblico, con effetti negativi sulle imprese italiane;
- crisi economica dovuta alla pandemia di Covid-19 (2020): blocco delle attività, restrizioni sanitarie e incertezza causano una recessione globale, con impatti su molte imprese nei settori della ristorazione, del turismo, e del commercio al dettaglio ma anche quelle manifatturiere;
- crisi inflazionistica globale (2022): aumento dei costi delle materie prime e dell'energia creano forti pressioni sulle imprese, con un aumento dell'inflazione che colpisce i consumatori e le catene di approvvigionamento;
- Crisi Ucraina (2022 e oltre): aumenti dei prezzi dell'energia e incertezze geopolitiche mettono a dura prova molte imprese che dipendono dalle importazioni di energia o da mercati internazionali.
L’elenco di cause esterne è dunque infinito e aggiornabile mese per mese, non solo anno per anno.
CAUSE INTERNE

Viene quindi logico pensare che il precipitato di questi eventi stressanti consecutivi, cui ora possiamo aggiungere l’effetto destabilizzante di Trump e quello dei dazi, sia un aumento progressivo di crisi e fallimenti delle imprese.
L’aumento che vediamo bene nei dati di Cerved:
+9,8% nel 2023;
+17,2% nel 2024;
+10,1% previsto per il 2025.
Sono numeri che raccontano una costante selezione naturale, che vede sopravvivere un gruppo di imprese forti, solide e grandi – le imprese che riescono a cambiare – ma che al sistema economico costa in termini di PIL, di numero di occupati e di competenze perse per strada.
Il costo è legato al tempo impiegato dalle imprese per riorganizzarsi, dalle persone per ricollocarsi, e dal sistema o dal singolo comparto per riattivarsi ed esprimere prodotti e servizi nuovi ed alternativi; misura così il dolore con cui si affronta ogni distruzione creatrice.
Nel tempo si susseguono però cause di crisi e fallimenti diverse.
Dobbiamo quindi armarci della lucidità sufficiente a distinguere le cause improvvise – quelle che accelerano la distruzione ma garantiscono ed anzi stimolano una nuova creazione – da quelle durevoli, che rappresentano una colpa per le imprese, non una sfortuna passeggera.
Cause interne che spesso sono la causa di lente e doorose agonie.
È infatti molto più coraggioso affrontare le cause interne e durevoli che consentono ad ogni crisi esterna di poter diventare la botta decisiva, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sulle crisi esterne che cambiano in continuazione e non fanno che aggravare uno stato di salute già precario.
DOVE INTERVENIRE

Dall’esterno possono infatti arrivare gli stimoli negativi come le intemperie dei mercati, le spinte dell’inflazione, gli appesantimenti dei dazi, l’incremento improvviso dei costi energetici o un blocco produttivo per ragioni sanitarie o geopolitiche.
Ma possono arrivare anche stimoli positivi come un’impennata della domanda, agevolazioni fiscali per l’acquisto di macchinari o assunzioni di personale, bonus ai consumatori per acquisti, ristrutturazioni e conversioni, moratorie sui debiti che danno ossigeno al respiro finanziario dell’impresa.
Negativi o positivi, questi stimoli imprevisti non possono però essere elementi su cui l’impresa sceglie di puntare e prendere le proprie decisioni per il futuro. Rimangono un campo da gioco per elementi di tattica da rivedere costantemente e su cui non è possibile fare affidamento.
Ne sanno qualcosa le imprese dell’edilizia e delle costruzioni ora rimaste senza bonus – un detto americano dice che quando la marea si abbassa vedi chi era senza mutande – ed anche le imprese che sperano in una moratoria dei debiti con l’erario per portarsi in attivo dopo tanti anni.
Alla radice di moltissime delle crisi, dei fallimenti ed anche delle liquidazioni di così tante imprese – ed è questo lo spazio in cui intervenire con radicali cambiamenti – ci sono quindi cause lunghe, che partono da lontano.
E si annidano qui:
- nell’ambito della finanza, della liquidità e della cassa;
- ed in quello del modello di business, del posizionamento, dei margini.
Nel primo soffrono di più le imprese che non hanno mai trovato un’organizzazione efficiente tra tempi di pagamento e tempi di riscossione, che non hanno la forza di sedersi al tavolo con i clienti o con i fornitori per evitare di essere la banca degli uni e degli altri.
E nel secondo ci sono le imprese che sopravvivono, ma che da quando sono nate non hanno mai fatto margini sufficienti, se non con l’aiuto del fisco oppure nonostante il fisco, perché non hanno costruito un modello di business adeguato a produrli.
I momenti stravolgenti come questo, però, sono quelli giusti per intervenire su entrambi i fronti.
* Coordinatore Centro Studi Imprese Territorio di Artser
