La filiera corta regge solo su fiducia e cooperazione tra produttori e territorio
Prezioso (Tor Vergata): senza reti di cooperazione territoriale e governance dal basso, i piccoli produttori non hanno gli strumenti per competere sul mercato

La filiera corta non è una moda, né un’etichetta commerciale. È un modello economico e sociale che mette al centro fiducia, prossimità e sostenibilità. A sostenerlo è la professoressa Maria Prezioso, docente di Economic/Political Geography and Economics and Territorial Planning all’Università di Roma Tor Vergata, analizzando il ruolo delle relazioni territoriali nello sviluppo locale. Dalle aree montane degli Appennini alle città rurali, passando per i modelli di governance multilivello e le sfide della transizione ecologica, la docente traccia un quadro in cui piccoli produttori, comunità locali e istituzioni sono chiamati a collaborare per costruire reti solide e durature.
FIDUCIA E COESIONE: IL BINOMIO CHE SOSTIENE LO SVILUPPO
Secondo Prezioso, il legame tra coesione territoriale e sviluppo è di lunga data: «Il rapporto tra coesione territoriale e sviluppo è da sempre, addirittura prima della politica di coesione dell’Unione Europea». Lo sviluppo, ha spiegato, va distinto dalla semplice crescita: «È attinente al concetto di accrescimento equilibrato e progressivo e lento, molto più lento rispetto a un concetto di crescita che guarda solo all’aumento di dimensione». La filiera corta, in questo senso, «funziona proprio se coesione e sviluppo diventano il veicolo della fiducia tra produttori e consumatori, anche di piccole dimensioni»
PROSSIMITA' E KM 0
Il tema della prossimità, oggi tradotto con l’espressione “chilometro zero”, è per Prezioso molto più che una scelta di consumo. «Quando parliamo di relazione di prossimità parliamo di interazione, e l’interazione avviene su un territorio che è sempre diverso in ogni sua geodeferenziazione». In alcuni territori, come l’Abruzzo o le aree alpine, la filiera corta si è consolidata fino a diventare «elemento connotante dell’identità locale». In altri casi, invece, resta confinata a dinamiche interne: «Lo sforzo dovrebbe essere quello di trasformarle in patrimonio più ampio di mercato, rendendole identificate e riconoscibili anche nel prezzo».
DALLA PRODUZIONE ALLA MANIFATTURA
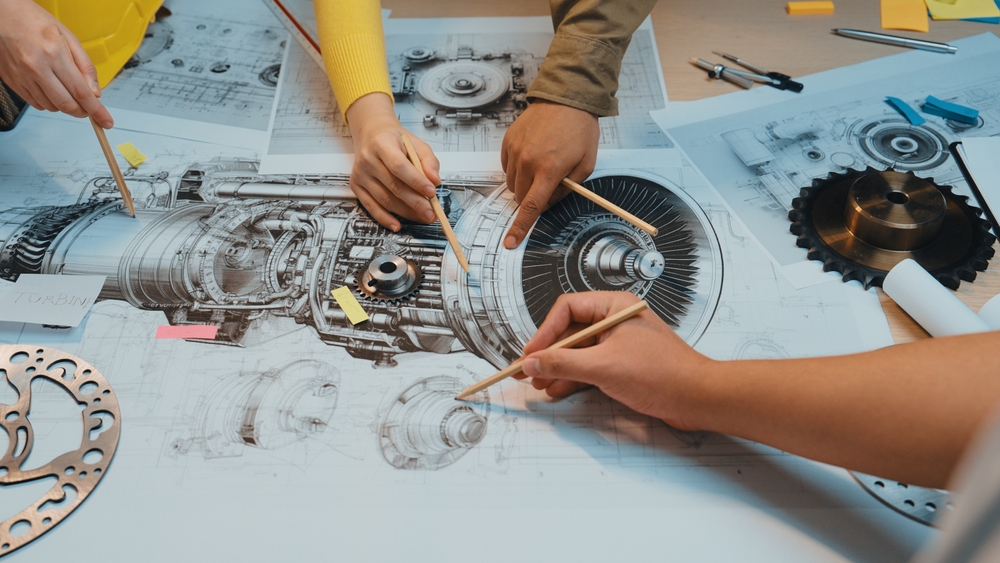
La filiera corta, ha sottolineato la professoressa, non riguarda solo il comparto alimentare. In molte realtà territoriali diventa un sistema integrato, in cui artigianato, turismo e risorse ambientali si intrecciano.
Secondo Prezioso, le filiere corte più avanzate si distinguono perché riescono a:
- coinvolgere diversi settori produttivi, dall’agroalimentare all’artigianato;
- valorizzare le risorse locali senza disperderle, dal legno ai boschi fino al turismo lento;
- proteggere la biodiversità e l’ambiente naturale;
- creare comunità di pratica, in cui cittadini e imprese collaborano direttamente.
«Tutti i pezzi della filiera lavorano insieme», ha osservato, «e questo produce sistemi turistici altamente legati alla biodiversità e alla protezione dei luoghi».
GOVERNANCE MULTILIVELLO
Il nodo istituzionale rimane delicato. «Ci deve essere una piena sintonia, sia normativa che regolamentativa e operativa, tra i vari livelli della gestione economica, territoriale e sociale», ha affermato Prezioso. Il passaggio più difficile è quello «dalle regioni alle realtà comunali o locali». Spesso i piani regionali non rispondono ai bisogni concreti dei territori: «Preferiamo suggerire piani fatti nell’ambito di comunità locali e di local action plan, cioè piani flessibili, aperti dal basso, contenenti prima di tutto la domanda e poi un’offerta appropriata».
STRUMENTI PER I PICCOLI PRODUTTORI

La filiera corta può rappresentare una chance per le microimprese, ma la dimensione resta un ostacolo. «I piccoli produttori non riescono ad adottarsi di tutti quegli strumenti che permettono di essere competitivi», ha detto la professoressa. La risposta, ancora una volta, è nella cooperazione: «Il sistema della condivisione e partecipazione diventa rete. Le strutture di cooperazione territoriale consentono di sopperire a queste limitazioni, di avere accesso ai mercati, ai fondi, alle strategie comuni». Si tratta del modello, dell’Ente di cooperazione territoriale, già utilizzato in altri Paesi europei come Lussemburgo, Francia e Germania, ma poco in Italia.
POLICENTRISMO E INNOVAZIONE
Prezioso ha richiamato il modello policentrico, che in Inghilterra ha dato risultati significativi: «Il policentrismo significa che ognuno partecipa allo sviluppo con le proprie risorse, attitudini e capacità e insieme riescono a fare massa critica». Piccole città e aree rurali, che da sole non avrebbero la forza di sostenere attività produttive e occupazione, trovano così rappresentatività. «È fondamentale che ci sia un rapporto stretto tra urbano e rurale», ha ricordato, «perché spesso i consumatori sono di natura urbana, mentre la produzione avviene nelle aree rurali».
FILIERA CORTA E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Lo sguardo si sposta al futuro. «Seguiamo al nascere i cosiddetti ecosistemi di prossimità, che fanno il paio con gli ecosistemi urbani e rurali», ha detto Prezioso. La transizione ecologica, secondo la docente, «sta trovando un nuovo approccio, basato su un modello collaborativo e circolare, che chiede di abbandonare il modello tradizionale lineare per andare verso un modello pienamente sostenibile nel 2050». Un processo già avviato: «La cultura della sostenibilità ha forato le coscienze», ha osservato. «Oggi è in corso una fase di sperimentazione, non ancora di modelli strutturati, ma già capace di incidere sulle relazioni interne, sulla prossimità e sull’innovazione dei processi produttivi».
