News
Il valore del dato per una Pmi: chi lo usa bene diventa un fornitore di prodotti e servizi


“Servitizzazione“. La parola, di suo, non attira. Anzi suona come un insidioso scioglilingua. Ma quella traduzione dall’inglese «servitisation» in realtà nasconde una pratica che si perde nella notte de tempi: seguire il cliente che acquista un prodotto, e offrirgli un servizio legato al suo funzionamento.
Una pratica che può rendere anche in settori non necessariamente legati ad economie di scala (come può essere la multinazionale che produce turbine di aereo e che non vende il motore alle compagnie, bensì le «ore volo» del macchinario) ma riguardare un pacchetto cioè una serie di servizi comprensivi di assistenza continua sul bene - che, appunto, non viene acquistato dal cliente - e manutenzione continua, permettendo così di liberarsi dalla formazione di personale ad hoc e di concentrare risorse umane e investimenti sull’attività principale. «Il concetto, come lo intendiamo oggi, nasce negli ultimi 15-20 anni. Un fenomeno globale perché riguarda produttori di beni strumentali.
COSA FARE DEI DATI? USARLI PER I SERVIZI

All’ultima assemblea di Federmacchine è stato confermato che l’Italia esporta i 2/3 delle macchine che produce, quindi anche sul piano della servitizzazione opera in un’arena internazionale», spiega Marco Taisch, professore al dipartimento di Ingegneria gestionale al Politecnico di Milano e luminare della materia. «Vent’anni fa si cominciò a teorizzare il fenomeno nel mondo universitario con esempi significativi legati ad aziende che hanno investito in questa direzione con una sempre più veloce diffusione del concetto che viene portato all’attenzione negli ultimi anni fino a quando non si arriva all’“impresa 4.0“. Sino a quando, cioè, gli imprenditori non hanno cominciato a chiedersi cosa fare con i dati connessi alle macchine, intuendo la possibilità di monetizzare quei dati. In che modo? Vendendo servizi».
Dunque, l’imprenditore non vende solo la macchina, ma suggerisce al cliente come impiegarla al meglio attraverso la manutenzione preventiva (esempio: la sostituzione di un componente ad un determinato livello di utilizzo) ma anche predittiva (il monitoraggio di quel singolo componente e l’analisi con la più alta certezza che l’oggetto sta per rompersi o deteriorarsi, e che quindi va sostituito): tutto grazie ai rilevamenti, ai flussi di dati.
LE PMI SONO PRONTE?
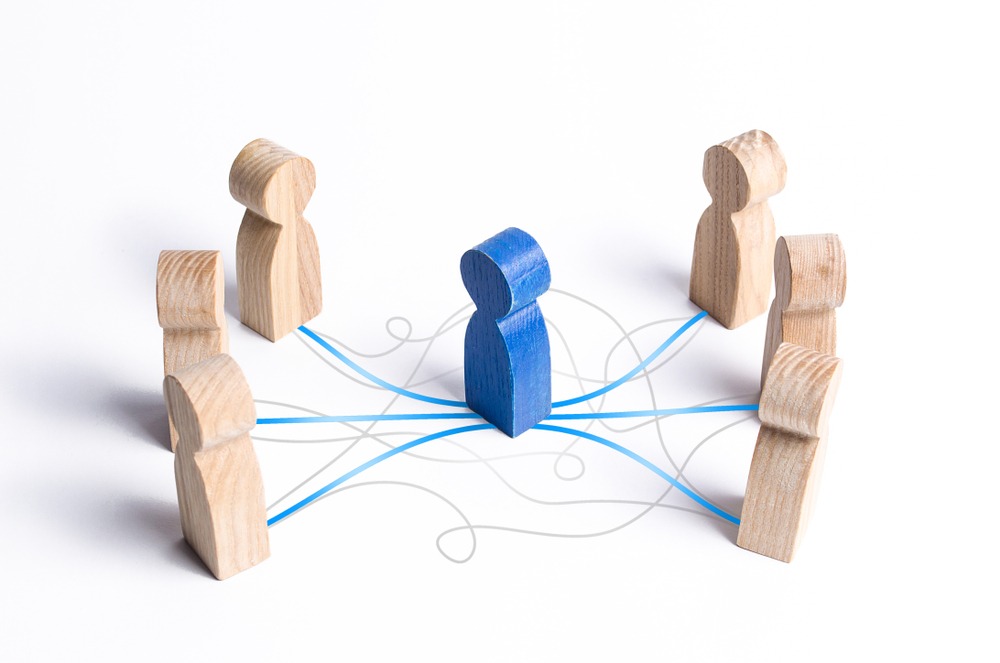
Materia affascinante, che combina la tecnologia con l’esigenza produttiva sfruttando le sempre maggiori potenzialità dell’informatica (e dell’onnipresente ragionamento derivante dall’arrivo dell’intelligenza artificiale). E qui arriva il nodo da sciogliere. Le Pmi sono pronte a questo passaggio? Come procedere, e con quali skills?
«Manca ancora la cultura, inteso come conoscenza della materia», spiega il professore. «Sono ancora poche le Pmi che incontro a convegni o seminari in cui si affronta il tema della servitizzazione. La strada è in salita, e lo è proprio per una capacità di interpretazione dei dati». Un esempio? «Sono un assemblatore di impianti, e vendo anche servizi al mio cliente. Quell’impianto è fatto da componenti che arrivano dai fornitori, che sono imprese artigiane. Io connetto l’impianto, ma i dati debbono essere raccolti da ogni componente di quell’impianto. Le Pmi produttrici di componenti utili all’azionamento di quel nastro trasportatore devono pensare ad un oggetto connesso, e in grado di raccogliere dati. Queste aziende, insomma, devono essere parte di questo modello di business, dare per scontato l’impiego di queste informazioni che assumono un valore elevatissimo nella gestione dei processi».
CONSIGLI PER SERVITIZZARE
Esistono regole per l’imprenditore che vuole investire in questo settore? Ci sono dei punti fermi “universali” da seguire? I consigli pratici da dare alle aziende che vogliono servitizzare.
- Creare la cultura del dato: i dati valgono tanto, occorre estrarre valore da dati. Misura, sensori, memoria, analisi.
- Guardare al consumatore finale: la servitizzazione è strettamente legata alla sostenibilità: se la mia auto è ben manutenuta, consuma meno ed è più sostenibile. Oramai il consumatore acquista un bene se sa che esiste un modello di business sostenibile.
- Investire in tecnologia digitale e conoscenza
- Prediligere prodotti che favoriscano la transizione ecologica.
Andrea Camurani

