Manifattura tra crisi e resistenza: il rebus dell’Italia produttiva
Tra shock globali, costi energetici e domanda debole, la manifattura italiana lotta per restare competitiva, divisa tra eccellenze reattive e settori in affanno

Negli ultimi anni la manifattura vive un declino a scatti: automotive e moda crollano, energia e carta reggono, ma tra delocalizzazioni, dazi e incertezze, la tenuta resta un enigma.
Tante, troppe, crisi; tanti punti interrogativi ai quali mancano – per ora – le risposte; tante incertezze e pochi convincimenti. La manifattura italiana si trova nel guado del cambio di rotta, ma quale sia questa rotta ancora non lo si è capito. E allora, non resta che chiederci se l’Italia possa mantenere anche in futuro il secondo posto sul podio del manifatturiero europeo dopo la Germania.
UN PROBLEMA COMUNE
A fare i conti con la debolezza della manifattura, d’altronde, è l’intero spettro europeo: l’automotive è in panne, l’inflazione e gli alti tassi hanno indebolito la domanda, le famiglie si dirigono sempre più sui servizi e sempre meno sui beni, i costi al rialzo dell’energia hanno colpito maggiormente quella che è, a tutti gli effetti, l’architrave dell’economia italiana: le piccole e medie imprese.
Ci affidiamo ai numeri per fare chiarezza, ma non per trovare conforto ad una situazione che rischia di attorcigliarsi su sé stessa: Confartigianato fa sapere, infatti, che a maggio 2025 l’indice della produzione manifatturiera ha registrato un calo congiunturale dello 0,7%. E se su base trimestrale si assiste ad una crescita dell’1%, nei primi cinque mesi dell’anno, in Italia, la produzione è scesa del 2,1%. La Germania si ferma a -1,6%, la Francia a -0,8% e la Spagna a -0,3%. Polonia e Irlanda trainano la media Ue portandola ad un +1,3%.
La stessa Banca d’Italia ha messo l’accento su un andamento economico che non lascia spazio all’immaginazione: il 32% delle imprese manifatturiere italiane e il 12% di quelle dei servizi (realtà con più di 50 dipendenti), temono pesanti ripercussioni derivanti dall’annunciata applicazione dei dazi statunitensi. Le nostre imprese, fortemente interconnesse con le filiere europee e globali, sanno che ci sarà un “effetto domino” su approvvigionamenti, esportazioni e marginalità.
CHI RALLENTA E CHI RESISTE
Negli ingranaggi rallentati del sistema imprenditoriale, ci sono però alcune eccezioni che bene rappresentano le unicità del Made in Italy: legno, carta e stampa aumentano la produzione del 2,6%, l’alimentare e le bevande dell’1,4% e i computer e l’elettronica dello 0,3%. Non c’è stata alcuna ripresa, invece, per due fra i maggiori settori dell’economia di casa nostra: la moda lascia a terra l’8%, mentre la meccanica il 3,5%. E in questo caso una sottolineatura va fatta, perché di fronte al crollo del 26,8% della produzione di autoveicoli, sembra non ci sia partita.
Restringendo il campo ai settori con una maggiore intensità energetica, si notano performance positive nella metallurgia (+3,3%) e, ancora una volta, nella carta, negli alimentari e nelle bevande. Che oscillano tra un +1,3% e +1,4%. A cedere sono, invece, la chimica (-1,1%), altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi come vetro, cemento e ceramica (-1,5%) e i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (-7,1%).
CRISI STRUTTURALE?
A questo punto, bisognerebbe rispondere ad una seconda domanda: si corre davvero il rischio che questo declino diventi strutturale?
Teoria e realtà, spesso, non coincidono. A dimostrarlo è proprio l’andamento a “due velocità” del tessuto imprenditoriale: da un lato, le aziende che da anni investono nell’export e, dall’altro, le Pmi “tradizionali” che dimostrano, ancora oggi, una bassa digitalizzazione, non sempre considerano la formazione come una scelta strategica e non sempre guardano alle nuove tecnologie come una soluzione alla scarsa marginalità. Insomma, la fotografia mette in luce le differenze tra imprese competitive e imprese fragili.
I FATTORI CHE STANNO ALLA BASE DELLA CRISI
Per completezza di informazione, il discorso si fa articolato. Perché se crisi c’è, la si deve anche ad un sistema economico italiano dove competitività ed efficienza produttiva sono strettamente legate ad un alto costo del lavoro che pone le aziende italiane in una condizione sfavorevole rispetto agli altri Paesi industrializzati. Si tratta di tre fattori che impattano direttamente sulle aziende, soprattutto sulle piccole e medie, perché ne ostacolano la crescita (in tempi di crisi gli investimenti sono cauti, se non nulli, perché gli imprenditori si dimostrano attendiste) e lo sviluppo tecnologico. Davide Ielmini
CONSULTA IL GRAFICO

Tre strategie che ridisegnano il futuro della manifattura italiana
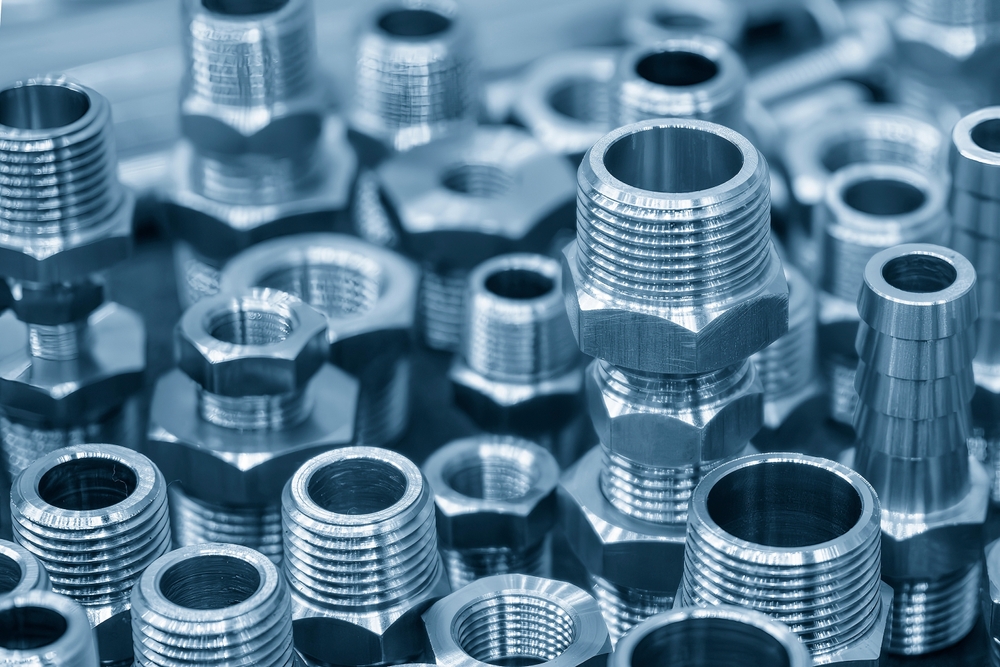
Dai tagli ai costi all’innovazione incrementale, le Pmi ribaltano la narrazione del declino con modelli competitivi flessibili e nuove prospettive di crescita
Negli ultimi anni, il dibattito pubblico e accademico sull’economia italiana è stato spesso dominato da una narrazione ricorrente: quella del declino inesorabile del nostro settore manifatturiero. Ma questa rappresentazione è davvero corretta? O si tratta, piuttosto, di un paradigma interpretativo riduttivo, che fatica a cogliere la complessità e le trasformazioni reali della manifattura italiana?
Per affrontare questi interrogativi, abbiamo intervistato il professor Alessandro Arrighetti, economista e docente ordinario alla Facoltà di Economia dell'Università di Parma, che propone una lettura alternativa e documentata del ruolo della manifattura nel nostro sistema economico a partire dalla classificazione delle diverse forme di competitività manifatturiera.
COMPETITIVITÀ MANIFATTURIERA
L'industria manifatturiera italiana è competitiva? «Molti osservatori rispondono di no, ma la realtà è più sfumata. Per comprendere meglio la questione, è necessario chiarire cosa intendiamo per “competitività”: questo concetto può essere analizzato da prospettive diverse e riferirsi a fenomeni distinti – chiarisce Arrighetti – In particolare, nel dibattito economico contemporaneo la competitività può essere interpretata secondo tre approcci teorici principali: a) Competitività basata su costi e prezzi – si concentra sulla riduzione dei costi di produzione e dei prezzi di vendita; b) Competitività fondata sull'innovazione radicale e di frontiera – punta sulla ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico avanzato e le innovazioni di rottura; c) Competitività basata sulla differenziazione e sull'innovazione incrementale – valorizza la varietà dei prodotti, la qualità, il design e il miglioramento continuo più che la competizione sui prezzi».
Questa pluralità di approcci è particolarmente importante per evitare letture distorte o eccessivamente semplicistiche del declino economico italiano, come quelle che imputano alla manifattura una presunta incapacità strutturale di adattarsi all’evoluzione tecnologica e organizzativa. Una visione, come spiegato da Arrighetti, che si fonda su presupposti teorici limitati e su indicatori che non riescono a cogliere la reale capacità competitiva del nostro sistema produttivo.
TRE APPROCCI

La competitività di costo si fonda su un paradigma di efficienza produttiva, in cui la capacità di ridurre i costi unitari – in particolare il costo del lavoro per unità di prodotto – è la leva principale per ottenere vantaggi nei mercati globali. «Questo modello competitivo è tipico di settori maturi, a basso contenuto tecnologico, dove la concorrenza si basa prevalentemente sul prezzo, ma è adottato anche da imprese che operano in settori relativamente avanzati – sottolinea Arrighetti – In Italia, come in altre economie europee avanzate, la strategia della compressione dei costi mostra limiti strutturali. Essa è spesso legata alla stagnazione degli investimenti e a un differenziale di costo del lavoro sfavorevole rispetto a paesi di più recente industrializzazione. Spesso competere soltanto sul prezzo è una strategia difensiva, con scarse prospettive di successo nel lungo periodo. Per mantenere bassi i prezzi le imprese tendono a ridurre i costi evitando di rinnovare gli impianti e i prodotti, rinunciando all'acquisto di nuove tecnologie e limitando l’assunzione di forza lavoro qualificata. Nel breve periodo, questi tagli consentono alle aziende di ottenere margini di profitto temporaneamente positivi, ma al prezzo di impoverire il capitale di conoscenze interno e di deprimere le potenzialità di crescita futura. In fondo, la possibilità di comprimere i costi in un’economia aperta è limitata e tende a esaurirsi rapidamente se non è sostenuta da innovazioni tecnologiche (e dai relativi investimenti) che incrementino l’efficienza. Come dimostrano recenti studi (Costa et al., 2023), non sono poche le imprese manifatturiere italiane che adottano questo modello strategico».
La seconda forma di competitività è quella basata sull’innovazione radicale e sul controllo delle tecnologie di frontiera. «Questo approccio è caratterizzato da elevati investimenti in Ricerca & Sviluppo (R&S), un’intensa attività brevettuale, stretti legami con università e centri di ricerca e dall’impiego di capitale umano altamente qualificato. Le imprese che seguono questa traiettoria competono introducendo prodotti e processi totalmente nuovi, spesso in settori ad alta tecnologia (come aerospazio, farmaceutica, automazione industriale o ICT), ridefinendo di fatto i paradigmi competitivi del proprio mercato. Tuttavia, non è facile per un sistema produttivo riconfigurarsi in breve tempo su queste attività di frontiera – evidenzia Arrighetti – Come evidenziano Archibugi, Mariella e Vezzani (2025), la specializzazione tecnologica di un paese tende a cambiare lentamente: ciascun sistema innova prevalentemente nei campi in cui ha già accumulato competenze, il che rende difficile spostarsi rapidamente verso nuovi settori emergenti. L’Italia, in questo scenario, occupa una posizione intermedia. Da un lato il nostro Paese non figura tra i leader mondiali nella maggior parte delle tecnologie emergenti; dall’altro può contare su competenze consolidate in alcuni ambiti di nicchia, ad esempio nella meccatronica, nei materiali avanzati e in certe tecnologie green. Inoltre, secondo lo studio citato, l’Italia avrebbe margini per aumentare la propria competitività anche in settori ad elevato tasso di crescita futura come la robotica, le tecnologie per la transizione ecologica e i macchinari industriali complessi, a patto di adottare politiche industriali mirate e coordinate».
La terza forma di competitività – particolarmente rilevante nel caso italiano – è quella incentrata sulla differenziazione dei prodotti, sulla varietà e sull’innovazione incrementale. «Questo modello non richiede necessariamente di collocarsi sulla frontiera tecnologica, ma si basa sulla capacità delle imprese di adattarsi continuamente alle esigenze del mercato, offrire prodotti personalizzati e valorizzare il proprio know-how progettuale – puntualizza Arrighetti – È la strategia tipica di molti settori del manifatturiero italiano, dove contano la qualità, il design e la flessibilità produttiva più che la produzione su larga scala o il prezzo minimo». Come documentano Arrighetti et al. (2024), molte imprese manifatturiere italiane riescono a competere efficacemente non perché tagliano i costi, ma perché creano valore aggiunto attraverso la divisione del lavoro tra imprese, la specializzazione flessibile e continui miglioramenti di prodotto e di processo.
Non un segnale di arretratezza, dunque, ma una strategia che riflette una forma sofisticata di efficienza basata sulla capacità di adattamento, sulla valorizzazione delle competenze tacite e sulla personalizzazione dei processi. Il sistema produttivo italiano ha mostrato, in più occasioni, una notevole resilienza e adattabilità: secondo Arrighetti et al. (2024), l’idea di un’industria irrimediabilmente inefficiente è più un costrutto ideologico che un dato empirico.
COSTI, INNOVAZIONE E COMMERCIO ESTERO
Dal punto di vista empirico, ciascuno dei tre modelli descritti chiama in causa indicatori diversi per misurare la competitività. Nel primo modello (costo/prezzo) le variabili di riferimento sono l’andamento dei costi degli input e dei prezzi dei prodotti; nel secondo modello (innovazione radicale) gli indicatori chiave sono la spesa in R&S e il numero di brevetti; nel terzo modello (differenziazione diffusa) assumono rilievo misure come le quote di mercato estero e i saldi commerciali.
«Le evidenze disponibili sui primi due fronti non sono incoraggianti per l’Italia. Come rileva Istat (2023) con riferimento al 2022, il settore manifatturiero italiano ha registrato un aumento del costo del lavoro per occupato accompagnato da un calo della produttività per addetto (+2,7%). Questo ha determinato un incremento del costo del lavoro per unità di prodotto (il Clup) del +5,2%. Allo stesso tempo, i costi intermedi unitari sono lievitati di un ulteriore +17,9%. La combinazione di questi fattori ha portato a una contrazione dei margini di profitto medi del settore pari a circa -1,4%. In altre parole, i produttori italiani hanno subìto un incremento dei costi più rapido dei guadagni di efficienza, erodendo la competitività di prezzo – rimarca ancora Arrighetti – Anche sul fronte dell’innovazione formale i dati mostrano un ritardo: come evidenziato dalla Figura 1, l’Italia presenta un rapporto tra spesa in R&S e PIL molto inferiore alla media europea. In effetti la spesa italiana in R&S si attesta attorno all’1,4% del PIL, a fronte di una media UE oltre il 2% (circa il 3% in Germania). Questo gap indica una minore intensità innovativa formale del nostro sistema produttivo rispetto ai principali concorrenti. In sintesi, considerando gli indicatori di costo/prezzo e quelli di innovazione tecnologica di frontiera, il posizionamento dell’Italia appare debole».
Fig. 1. Spesa in RS sul Pil in Europa
Vi è però un’evidenza empirica in netto contrasto con questo quadro negativo ed emerge analizzando la competitività secondo il terzo modello. «Se adottiamo la prospettiva della capacità di un sistema industriale di sostenere la competizione globale nel suo complesso, il caso italiano risulta molto più positivo – aggiunge Arrighetti – Secondo l’impostazione di Singh (1987), un sistema manifatturiero nazionale è competitivo quando riesce a esportare un volume di beni almeno pari a quello dei beni che deve importare. Un indicatore sintetico di questa capacità è il saldo commerciale normalizzato, calcolato come (Export – Import) / (Export + Import): un valore vicino o superiore a zero indica che il sistema vende all’estero almeno quanto acquista, mentre un valore negativo segnala il contrario, evidenziando una perdita di competitività aggregata».
In un’epoca di crescente apertura dei mercati internazionali, questo parametro assume grande importanza, soprattutto per valutare quella competitività “diffusa” basata su tante imprese flessibili e orientate all’export (il terzo modello sopra descritto). «Adottando questa lente interpretativa, la posizione dell’Italia risulta molto migliore di quanto appaia dai soli indicatori di costo o di innovazione di frontiera – osserva il professore – La Figura 2 illustra l’andamento dei saldi commerciali normalizzati delle principali economie mondiali dal 2000 al 2022 (dati di Arrighetti, De Nardis e Traù, 2024). Inizialmente quattro grandi Paesi manifatturieri – Germania, Francia, Giappone e Italia – presentavano un saldo commerciale normalizzato positivo, ma negli anni successivi i primi tre hanno visto questo indicatore ridursi (fino a diventare negativo per la Francia), mentre l’Italia ha registrato un costante, anche se limitato, miglioramento. In altre parole, la competitività complessiva del manifatturiero italiano è cresciuta nel tempo, tanto che oggi l’Italia vanta un surplus industriale estero superiore a quello di molti concorrenti».
Fig. 2 Saldi commerciali normalizzati di Germania, Francia, UK, Giappone e US
Fonte: Arrighetti, De Nardis e Traù 2024
Gli Stati Uniti «mostrano invece una tendenza opposta: la competitività manifatturiera americana è diminuita costantemente. In questo caso, la debolezza non dipende solo dalla pressione delle importazioni, ma anche dalla scarsa capacità dei prodotti statunitensi di affermarsi sui mercati esteri».
UN FENOMENO ARTICOLATO
In sintesi, l’analisi del professor Arrighetti mostra quanto la competitività manifatturiera italiana sia un fenomeno articolato che non può essere valutato attraverso un’unica lente di osservazione. «Esaminare il sistema industriale con approcci diversi consente di mettere in evidenza le debolezze di alcune componenti ma anche la forza di altri segmenti produttivi, spesso poco considerati nel dibattito corrente – conclude – I tradizionali indicatori di costo e innovazione tecnologica segnalano criticità importanti: l’Italia fatica a tenere il passo in termini di produttività e investimenti in R&S. Tuttavia, emergono anche elementi di vitalità competitiva legati al modello della differenziazione diffusa: la capacità di tante imprese di esportare con successo e bilanciare le importazioni è un segnale di dinamismo da non trascurare».
Rivedere i presupposti teorici con cui si misura l’efficienza industriale diventa quindi un passaggio obbligato per comprendere appieno il ruolo attuale e futuro della manifattura italiana. Solo superando la cornice cognitiva dominante e considerando il reale dinamismo della manifattura italiana è possibile costruire politiche industriali realmente efficaci grazie a una chiave di lettura coerente con la reale capacità competitiva del nostro sistema produttivo. Paola Mattavelli
