News
Gas e tensioni globali: perché senza nuove alleanze le Pmi rischiano il tracollo

«Non illudiamoci: la tensione in Medio Oriente è ancora alta e a pagare il conto più salato saranno le nostre piccole e medie imprese. La bolletta energetica non si sgonfierà: o l’Italia, una volta finita la guerra in Ucraina, si siederà al tavolo delle trattative con la Federazione Russa, oppure il declino sarà inarrestabile. La nostra politica estera guardi ai mercati in espansione – come Vietnam e Indonesia – e lavori per la pace: questa è la sola, unica, soluzione che potrà dare un futuro alle Pmi». A dirlo è Demostenes Floros, Senior Energy Economist al CER-Centro Europa Ricerche e autore di "Guerra e Pace dell'Energia. La strategia per il gas naturale dell'Italia tra Federazione russa e Nato" e "Crisi o Transizione Energetica?". Il prossimo anno, insegnerà Geopolitica dell’energia all’Università di Padova.
Professore, fare previsioni è difficile: la situazione tra Israele, Iran e Stati Uniti è davvero chiusa?
Una breve premessa: in Italia, chi si occupa di energia spesso la tratta esclusivamente da un punto di vista tecnico. Poi, viene la geopolitica: io faccio l’opposto. Per entrare nel tema: il CER ha iniziato a porre alcune domande spinose prima ancora dell’estensione del conflitto tra Russia e Ucraina dopo il 24 febbraio 2022. Per un semplice motivo: il prezzo del gas naturale nel mercato regionale europeo (Ttf) ha iniziato ad aumentare, in modo costante e continuo, dal mese di marzo 2021. E chi pensa che la questione in Medio Oriente sia chiusa, sbaglia di grosso.

Quali sono i motivi?
In virtù del suo paniere energetico, l’Italia è il Paese più svantaggiato tra le principali economie del Globo: tra il 2021 e il 2022 ha utilizzato il gas naturale per circa il 40% dei propri consumi di energia primaria e il petrolio si è fermato al 38%. Costi che ricadono soprattutto sulle piccole e medie imprese. Se ne sono accorti in pochi, ma questo è il vero paradosso: il gas naturale, tra le fonti fossili, è quella che emette meno CO2. Eppure, il nostro Paese ha registrato in bolletta l’incremento maggiore tra tutti i paesi. I dati Fmi chiariscono il problema: nel 2021, l’incremento mondiale dei prezzi dell’energia si aggirava intorno al 100%. Gli Stati Uniti erano al di sotto del 70%, la Francia era poco sopra questa percentuale, India e Cina si avvicinavano alla media mondiale, mentre le due principali economie manifatturiere europee – Italia e Germania – hanno registrato incrementi che oscillavano tra il 130% e il 170%.
Cosa è accaduto?
I fattori che incidono sull’aumento della bolletta energetica sono diversi: di mercato, legati alla transizione energetica, geopolitici. La maggior parte degli analisti si è concentrata sui fattori di mercato, ricordando quanto il consumo di energia, dopo il Covid 19, fosse aumentato. E con questo anche i prezzi. In effetti, la domanda di gas naturale nella Ue aveva registrato un rialzo di circa il 6%, ma i prezzi al Ttf (mercato di scambio del gas naturale in Europa e punto di riferimento per determinare il prezzo all’ingrosso della materia prima) erano balzati ad un +400%. I fattori riconducibili alla transizione energetica si spiegano con i certificati di emissione: anche in questo caso il prezzo è aumentato in modo significativo. Il fattore principale, però, è un altro.
Quale?
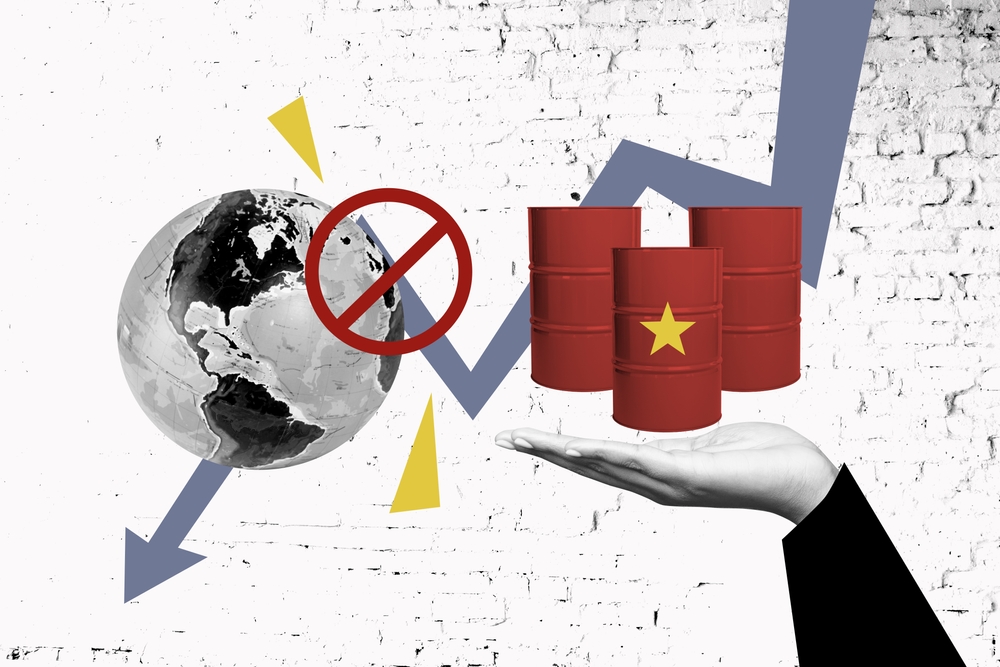
È cambiata la modalità di acquisto del gas naturale: dalla fine degli anni Settanta, fino al decennio trascorso, la materia prima veniva venduta dalla Federazione Russa (ex Urss) alla Ue con contratti a lungo, o lunghissimo periodo (anche trent’anni), nei quali il prezzo del gas naturale dipendeva da quello del petrolio (contratti cosiddetti take or pay oil-link). I prezzi erano tendenzialmente stabili e nella fornitura non c’è mai stata alcuna interruzione. Poi, con l’intervento di Bruxelles, i contratti sono stati modificati sulla scia del mercato regionale nordamericano.
In che senso?
Dai contratti take or pay (quantità) oil-link (prezzo), si è passati ai contratti spot (quantità) hub (prezzo) cioè, su acquisti a maggioranza spot e con il prezzo del gas naturale non più agganciato a quello del petrolio, bensì definito dal gioco della domanda/offerta di un hub (il Ttf). L’Europa ha iniziato a comprare la materia prima solo quando ne aveva più bisogno; invece, il gas si stocca soprattutto in un periodo dell’anno e lo si consuma, soprattutto, in un altro. Con l’attacco della Russia all’Ucraina, e il sabotaggio e la distruzione dei gasdotti, si arriva ad una ulteriore limitazione dell’offerta della materia prima. Insomma, la scelta di Bruxelles non era affatto disinteressata, perché arrivava direttamente dall’altra parte dell’Oceano. Infatti, la Ue ha sostituito – seppur, parzialmente – i volumi di gas naturale della Russia con il Gnl (gas naturale liquefatto) proveniente dagli Stati Uniti. Che costa molto di più e inquina di più. Nessuno, inoltre, ha considerato il fatto che ad aiutare l’Italia e l’Ue è stato il clima: nel 2021-2022 e nel 2022-2023, infatti, la stagione fredda è stata particolarmente mite. In caso contrario, avremmo avuto un razionamento nel consumo della materia prima del gas naturale. Comunque, questa situazione ha portato a più di due anni di produzione manifatturiera negativa. E la crisi continua.
Si ritornerà mai alle quotazioni del 2021?
Innanzitutto, le importazioni di gas naturale dalla Russia difficilmente potranno essere eliminate, così come vuole la Ue, entro il 2027. Inoltre, ricordo che il conflitto tra Israele e Iran non è solo sul petrolio ma anche sul gas. E l’Italia, ma anche la Germania e buona parte dei Paesi europei, proprio per sostituire parzialmente l’importazione di gas naturale dalla Federazione Russa si sono legati al Qatar. Secondo esportatore al mondo di gas naturale liquido. Che passa dallo stretto di Hormuz: se si blocca il petrolio, si blocca anche il gas naturale liquefatto qatariota (ed emiratino).
I numeri parlano chiaro?

Con la cosiddetta “guerra dei 12 giorni”, il prezzo del petrolio al barile ha sfondato gli 80 dollari e il gas naturale ha superato i 40 euro al Megawattora (MWh). Tra il 2009 e il 2021, invece, i prezzi al Ttf in Europa si aggiravano sui 19,2 euro al MWh, e il gas russo era il più conveniente. Ora, siamo entrati in una nuova fase e non si potrà fare marcia indietro: ogni nuova crisi in Medio Oriente aumenterà il prezzo del gas europeo e asiatico e le imprese troveranno più conveniente prendere la via del Nord America. Comunque sia, la Ue difficilmente risolverà il problema energetico affidandosi a Norvegia, Algeria o Azerbaigian, Paesi che non mancano di problemi o limiti. Qualsiasi intoppo nelle forniture, anche una semplice manutenzione straordinaria, ricadrà immediatamente sulle piccole e medie imprese.
Secondo Confartigianato, nelle ultime settimane del conflitto tra Israele e Iran il 36% delle Pmi aveva già subito impatti diretti: è possibile una “corsa ai ripari” da parte degli imprenditori?
Credo che l’Italia, tra i paesi più industrializzati della Ue, rischi di pagare il conto più salato. L’unica mossa possibile è fare grandi pressioni sulla politica: quella al governo e quella all’opposizione. È tempo di convincersi che l’Italia deve difendere la propria autonomia e i propri interessi nazionali. E se per farlo dovrà sedersi con la Federazione Russa ai tavoli delle trattative, lo faccia. Se non rinnoverà questo dialogo, economico e commerciale, l’aumento del declino sarà costante e l’Unione europea farà sempre più fatica. Pensi anche alla transizione energetica: non si può fare dall’oggi al domani. Bisogna per forza rivedere le scadenze, i costi sono insostenibili!

Le imprese chiedono misure urgenti: defiscalizzazione strutturale delle accise sui carburanti, fondo di compensazione per le realtà energivore, accelerazione reale sui Pnrr energia per impianti rinnovabili, snellimento dei processi autorizzativi per fotovoltaico industriale, incentivi per accelerare il ricambio verso flotte ecologiche. Cosa si può fare?
Sono tutte proposte condivisibili, ma estremamente deboli rispetto alla gravità della crisi in essere. L’unica speranza per la Ue e l’Italia è lavorare per un contesto internazionale stabile, dove la priorità dovrà essere la de-escalation. Inoltre, la nostra politica estera dovrà guardare a quei grandi mercati dell’Asia che sono già cresciuti o che cresceranno nel prossimo futuro – per esempio, il Vietnam e l’Indonesia – soppesando i rapporti di forza che muovono il mondo. Al di fuori di un “quadro di pace”, le piccole e medie imprese rischieranno di essere spazzate via dai mercati. Nel 2022, avevo anticipato il processo di deindustrializzazione dell’Italia e della Ue: spero che la situazione non degeneri, ma non sono affatto fiducioso. Davide Ielmini

