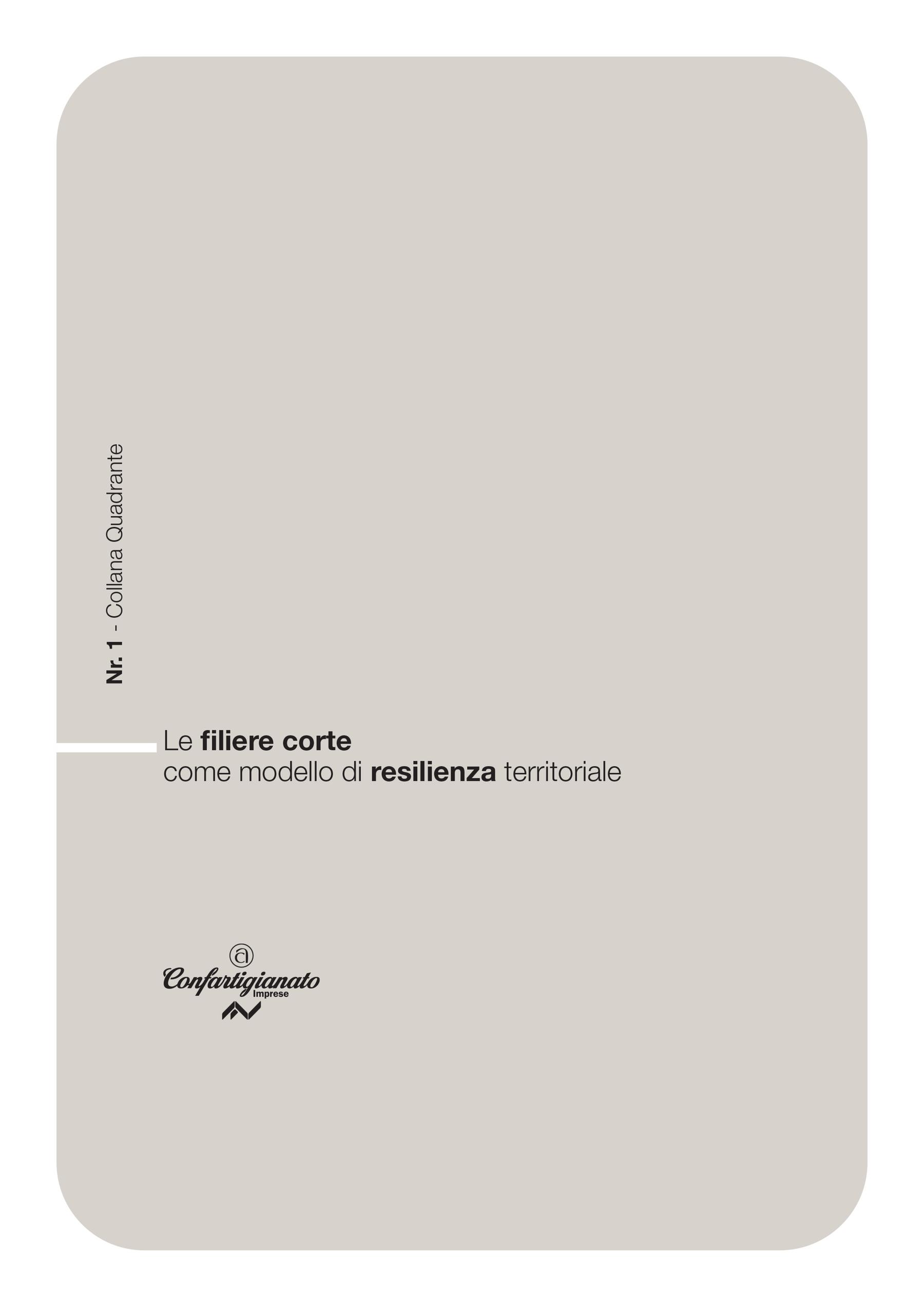Filiere corte: perché funzionano (e dove si fermano)
Aggiornato a novembre 2025
Le filiere corte rappresentano oggi uno dei pochi modelli capaci di unire competitività e radicamento territoriale. Non si oppongono alla globalizzazione: ne correggono gli eccessi, valorizzando ciò che i grandi sistemi non riescono a replicare. Prossimità, relazioni dense, conoscenza tacita, specializzazioni mature. È in questo equilibrio tra saper fare, fiducia e cooperazione informale che molti territori – Varese in primis – hanno trovato la forza per assorbire choc, riconfigurare produzioni, innovare senza perdere identità.
La ricerca mostra che la resilienza osservata non dipende da pianificazioni centralizzate, ma da dinamiche spontanee di auto-organizzazione: reti che apprendono, imprese che si riconfigurano, competenze che circolano. Un sistema vivo, capace di adattarsi rapidamente perché fondato su relazioni e cognizioni condivise.
Accanto ai punti di forza emergono però limiti strutturali: carenza di competenze, pressione burocratica, difficoltà nell’affrontare innovazioni radicali, rischi di lock-in culturali. Perché le filiere corte restino un asset strategico occorrono condizioni abilitanti: infrastrutture adeguate, formazione orientata alla pratica, semplificazione reale, investimenti pazienti e politiche che accompagnino il sistema, non che lo sostituiscano.
Le filiere corte non sono un modello nostalgico. Sono un laboratorio avanzato per ripensare lo sviluppo, a partire dal territorio e dalla sua capacità di generare valore condiviso.